A Padova, in occasione della seconda edizione della BTRI, borsa turismo religioso internazionale,
“eductour” per la stampa di settore tra arte, tavola, arte e ancora tavola…
Ma quanto siamo ricchi di arte? (…e di tavola?) I giornalisti presenti non erano certo di “primo pelo”
ma proprio tutti sono rimasti a bocca aperta all’uscita da chiese e musei (e anche… dai ristoranti)
Complice una bella “ottobrata”
il viaggio-stampa - organizzato da DRAGOPRESS
- comincia
sotto i migliori auspici dal centro del capoluogo veneto con le tappe
previste, quelle canoniche della “città del Santo”: l’omonima
Basilica, l’Arena Romana, Duomo e Battistero, Cappella degli
Scrovegni, Chiesa degli Eremitani, il Ghetto ebraico con sinagoga e
museo, l’Orto Botanico (dal 1997 patrimonio dell’umanità Unesco)
il Palazzo della Ragione e l’Università 'Il Bò', frequentata da
Galileo, Copernico, dal Petrarca, ecc. La trasferta prevede anche
qualche digressione nei paraggi: nel quartiere Arcella alla chiesetta
intitolata a Santa Maria della Cella dove sant’Antonio fu condotto
morente, al santuario antoniano di Camposampiero, a Cittadella per
una piacevolissima passeggiata nel “camminamento delle ronde”
sulle mura restaurate, al castello di Monselice, al Palazzo e alla
loggetta del Monte di Pietà, alla chiesa di san Paolo e al museo
civico, fino al Santuario Giubilare delle Sette Chiese e alla villa
Nani-Mocenigo, siti per l’occasione amabilmente descritti
dall’esimio prof. Riccardo Ghidotti che ha affascinato i presenti
con le sue narrazioni.
Tra le variazioni sul tema, la visita al “museo della storia della Medicina”, sito in città nell’ex ospedale di san Francesco, ha lasciato tutti, inaspettatamente, esterrefatti: senza dubbio grande parte del merito va alla direttrice Elisa Salvato (…affetta da RLS??) travolgente nel descrivere il sapere medico dalle origini – dal codice Hammurabi alla medicina sapienziale fino a quella moderna – tra le sale dedicate all’anatomia, alla fisiologia, alla patologia e alla terapia, con trattazioni sull’apparato motorio, digerente e riproduttivo, sul sistema nervoso, occhio, orecchio, cuore e polmone, sugli anestetici, gli antibiotici e i vaccini e con la possibilità di sfogliare “veri” testi, antichi volumi ancora scritti a mano dagli scienziati, ma con tanto di traduzione – una struttura (avveniristica) che raccoglie, custodisce e valorizza testimonianze della cultura medica scientifica padovana, ma anche internazionale. Un complesso sistema - alla fine semplicissimo - dove è “vietato non toccare” (!) – gestito da apparati software e sistemi multimediali che permettono analisi in tempo reale, esami, visualizzazioni di scheletro, muscoli e organi umani in grandezza naturale, componibili e scomponibili, sezionabili e scrutabili all’infinitesimo da tutte le prospettive, guidati da voci digitali e non: un vero luna park per i visitatori più piccoli, che trovano diversi percorsi giocosi (e non vogliono più andare via…) ma in effetti scientificamente tutti attendibili anche per gli adulti, uomini, donne, e medici, chirurghi compresi!
Per i tanti operatori della comunicazione partecipanti a questo viaggio stampa - quasi tutti giunti ormai all’ennesima frequentazione del capoluogo veneto, in occasione di fiere, convegni (e per il sottoscritto anche per incontri enogastronomici… perché questa zona è famosa per "risi e bisi" e "pasta e fasoi", per il prosciutto Veneto Berico Euganeo, per il "bollito alla padovana", il radicchio e i formaggi… il “dolce di Federico II” e per concludere, il caffè “macchiato menta e zabaione”, tipicità sempre proposta dallo storico caffè Pedrocchi di piazza Cavour - lì da 200 anni! - "il caffè senza porte” aperto giorno e notte) - visitare un po’ meno frettolosamente e con tanto di guida esperta chiese, palazzi e musei, è stata davvero un’opportunità da non perdere e, così si impara che nella chiesa del Santo vi sono “lunette” che trasmettono la storia cristiana per mano di artisti quali Giotto, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Giambattista Tiepolo, Gianantonio Canal, più noto come Canaletto e ancora, Sebastiano del Piombo Lorenzo Lotto, Giusto de' Menabuoi, Altichiero, Vittore Carpaccio, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, il Pordenone e potremmo continuare per un altro paio di pagine… Infine assistendo incantati alla visita in notturna della cappella del Santo, con tanto di spiegazioni di fra’ Giuliano, squisitamente competente e lapidario nelle chiose (quando ci vuole… ci vuole!).
Ah dimenticavamo… Il viaggio stampa era stato organizzato per partecipare in primis alla “BTR” Borsa del Turismo Religioso Internazionale, con workshop per gli addetti ai lavori (che per inciso è stato ancora una volta un successo per operatori e visitatori) ma come spesso succede, le attività di contorno, per qualcuno…
– forse – hanno avuto più successo dell’evento principale! (Gianfranco Leonardi)
Tra le variazioni sul tema, la visita al “museo della storia della Medicina”, sito in città nell’ex ospedale di san Francesco, ha lasciato tutti, inaspettatamente, esterrefatti: senza dubbio grande parte del merito va alla direttrice Elisa Salvato (…affetta da RLS??) travolgente nel descrivere il sapere medico dalle origini – dal codice Hammurabi alla medicina sapienziale fino a quella moderna – tra le sale dedicate all’anatomia, alla fisiologia, alla patologia e alla terapia, con trattazioni sull’apparato motorio, digerente e riproduttivo, sul sistema nervoso, occhio, orecchio, cuore e polmone, sugli anestetici, gli antibiotici e i vaccini e con la possibilità di sfogliare “veri” testi, antichi volumi ancora scritti a mano dagli scienziati, ma con tanto di traduzione – una struttura (avveniristica) che raccoglie, custodisce e valorizza testimonianze della cultura medica scientifica padovana, ma anche internazionale. Un complesso sistema - alla fine semplicissimo - dove è “vietato non toccare” (!) – gestito da apparati software e sistemi multimediali che permettono analisi in tempo reale, esami, visualizzazioni di scheletro, muscoli e organi umani in grandezza naturale, componibili e scomponibili, sezionabili e scrutabili all’infinitesimo da tutte le prospettive, guidati da voci digitali e non: un vero luna park per i visitatori più piccoli, che trovano diversi percorsi giocosi (e non vogliono più andare via…) ma in effetti scientificamente tutti attendibili anche per gli adulti, uomini, donne, e medici, chirurghi compresi!
Per i tanti operatori della comunicazione partecipanti a questo viaggio stampa - quasi tutti giunti ormai all’ennesima frequentazione del capoluogo veneto, in occasione di fiere, convegni (e per il sottoscritto anche per incontri enogastronomici… perché questa zona è famosa per "risi e bisi" e "pasta e fasoi", per il prosciutto Veneto Berico Euganeo, per il "bollito alla padovana", il radicchio e i formaggi… il “dolce di Federico II” e per concludere, il caffè “macchiato menta e zabaione”, tipicità sempre proposta dallo storico caffè Pedrocchi di piazza Cavour - lì da 200 anni! - "il caffè senza porte” aperto giorno e notte) - visitare un po’ meno frettolosamente e con tanto di guida esperta chiese, palazzi e musei, è stata davvero un’opportunità da non perdere e, così si impara che nella chiesa del Santo vi sono “lunette” che trasmettono la storia cristiana per mano di artisti quali Giotto, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Giambattista Tiepolo, Gianantonio Canal, più noto come Canaletto e ancora, Sebastiano del Piombo Lorenzo Lotto, Giusto de' Menabuoi, Altichiero, Vittore Carpaccio, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, il Pordenone e potremmo continuare per un altro paio di pagine… Infine assistendo incantati alla visita in notturna della cappella del Santo, con tanto di spiegazioni di fra’ Giuliano, squisitamente competente e lapidario nelle chiose (quando ci vuole… ci vuole!).
Ah dimenticavamo… Il viaggio stampa era stato organizzato per partecipare in primis alla “BTR” Borsa del Turismo Religioso Internazionale, con workshop per gli addetti ai lavori (che per inciso è stato ancora una volta un successo per operatori e visitatori) ma come spesso succede, le attività di contorno, per qualcuno…
– forse – hanno avuto più successo dell’evento principale! (Gianfranco Leonardi)
+ BOX
Per
William Shakespeare:
“…fu grande il desiderio di vedere la bella Padova, culla delle arti…"
“…fu grande il desiderio di vedere la bella Padova, culla delle arti…"
Di
seguito i monumenti e le strutture che non si possono non vedere in
occasione di un viaggio a Padova e dintorni:
ARENA
ROMANA
L’antico
teatro romano di Padova, altresì detto Arena perché vi si spargeva
la sabbia (arena) e perché vi avvenivano i combattimenti dei
gladiatori prima e giostre e tornei dopo…
BASILICA
DEL SANTO
La
Basilica di Sant'Antonio, conosciuta con il nome "Il Santo",
è il centro religioso più importante della città
BATTISTERO
DEL DUOMO
Rappresenta
uno dei monumenti artistici più insigni della città
CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI
La
Cappella degli Scrovegni racchiude uno dei massimi capolavori della
pittura del Trecento italiano ed europeo
CHIESA
DEGLI EREMITANI
Antichissima
sede agostiniana, famosa per la Cappella Ovetari, uno dei capolavori
del Mantegna
ORTO
BOTANICO
Fondato
nel 1545 è il più antico orto botanico universitario del mondo.
Patrimonio UNESCO.
GHETTO
EBRAICO
A
sud della piazza delle Erbe si snoda un labirinto di strade strette
che formano il ghetto lì operante dal 1603 e abolito nel 1797
PALAZZO
DELLA RAGIONE
Lungo
82 metri e largo 27, il "Salone" si erge sopra un loggiato
trecentesco.
UNIVERSITA'
(palazzo il BO') la più antica (dopo Bologna) e frequentata da
Galileo, Copernico, Petrarca
MUSEO
DI STORIA DELLA MEDICINA (musme) Palazzo della Salute, la medicina
come non si è mai vista… un museo tra passato e futuro dove si
coniuga storia e tecnologia tra veri reperti antichi e exhibit
interattivi e con percorsi multimediali e ludici per i piccoli
visitatori. DA VEDERE!!
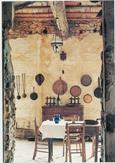
 Lo scopo del Museo è di mantenere viva la memoria di quella che, nei primi
anni del 1900, era la vita della comunità agricola della nostra zona.
Il materiale esposto proviene in buona parte dalle famiglie della Parrocchia,
e diversi attrezzi e mezzi agricoli sono stati donati anche dalle comunità limitrofe.
L’allestimento curato da professionisti, favorisce l’esposizione di moltissimi attrezzi
agricoli, utensili e oggetti (oltre un migliaio) che lo rendono uno dei più ricchi
e significativi Musei di questo genere.
Nell’ampia sala d’entrata sono esposti alcuni pannelli che ripercorrono la storia dell’Abbazia
di Carceri, dalla presenza dei Monaci Agostiniani all’inserimento dei Camaldolesi, fino
all’arrivo della nobile Famiglia dei Conti Carminati, conclusosi con il passaggio definitivo
del sito alla Parrocchia di Carceri. Sul fronte opposto una riproduzione illustrata
della giornata del Monaco Benedettino, ospite dell’Abbazia di Carceri.
Le quindici illustrazioni evidenziano le ore di lavoro, di preghiera e di riposo che
i Monaci dovevano affrontare quotidianamente.
Per una visita più attenta del Museo si propone questo itinerario:
Sala della preparazione e sistemazione della terra per la semina,
dove si possono vedere gli attrezzi per la semina e la sarchiatura,
la mietitura e la raccolta dei prodotti agricoli : frumento, erba medica,
barbabietole e granoturco.
Lo scopo del Museo è di mantenere viva la memoria di quella che, nei primi
anni del 1900, era la vita della comunità agricola della nostra zona.
Il materiale esposto proviene in buona parte dalle famiglie della Parrocchia,
e diversi attrezzi e mezzi agricoli sono stati donati anche dalle comunità limitrofe.
L’allestimento curato da professionisti, favorisce l’esposizione di moltissimi attrezzi
agricoli, utensili e oggetti (oltre un migliaio) che lo rendono uno dei più ricchi
e significativi Musei di questo genere.
Nell’ampia sala d’entrata sono esposti alcuni pannelli che ripercorrono la storia dell’Abbazia
di Carceri, dalla presenza dei Monaci Agostiniani all’inserimento dei Camaldolesi, fino
all’arrivo della nobile Famiglia dei Conti Carminati, conclusosi con il passaggio definitivo
del sito alla Parrocchia di Carceri. Sul fronte opposto una riproduzione illustrata
della giornata del Monaco Benedettino, ospite dell’Abbazia di Carceri.
Le quindici illustrazioni evidenziano le ore di lavoro, di preghiera e di riposo che
i Monaci dovevano affrontare quotidianamente.
Per una visita più attenta del Museo si propone questo itinerario:
Sala della preparazione e sistemazione della terra per la semina,
dove si possono vedere gli attrezzi per la semina e la sarchiatura,
la mietitura e la raccolta dei prodotti agricoli : frumento, erba medica,
barbabietole e granoturco.

 Continuando il percorso, dopo lo spazio dedicato alle Rogazioni, si possono intravvedere
i tantissimi attrezzi della Stalla, indispensabili nella gestione dei lavori e
degli animali che sostenevano l’attività agricola dei nostri nonni.
Nella parte interna si può visitare un’ampia Sala dedicata ai lavori domestici,
con tutti gli utensili della cucina, oltre lo spazio per la stiratura, per il
cucito, per la lavatura degli indumenti dei nostri avi e a completamento una stanza da letto,
munita degli accessori di una volta.
Nella parte finale si possono visitare la stanza dedicata alle unità
di peso e misura e una stanza con alcuni oggetti usati per il tempo libero.
Accanto uno spazio che racconta il percorso del vino, con gli attrezzi e gli
oggetti usati dai nonni.
Nella parte del Museo che si affaccia al grande Chiostro del 1500, sono state
allestite alcune sale dedicate ai lavori di quel tempo :
La Sala della Scuola e dei Giochi, la Sala della lavorazione della lana e della canapa,
la Sala del Calzolaio, la Sala del Falegname, e infine quella del fabbro
“ favaro “ e dell’arrotino “ moleta “ .
All’interno del Museo è stata prevista una Sala per le attività didattiche che
possono essere svolte dai bambini della Scuola Primaria durante la visita al
complesso Abbaziale.
Il percorso proposto per la visita al Museo rappresenta una testimonianza del lavoro svolto
dalle comunità dei Monaci Agostiniani e Camaldolesi per rendere viva e
autosufficiente l’esistenza dei nostri avi.
Continuando il percorso, dopo lo spazio dedicato alle Rogazioni, si possono intravvedere
i tantissimi attrezzi della Stalla, indispensabili nella gestione dei lavori e
degli animali che sostenevano l’attività agricola dei nostri nonni.
Nella parte interna si può visitare un’ampia Sala dedicata ai lavori domestici,
con tutti gli utensili della cucina, oltre lo spazio per la stiratura, per il
cucito, per la lavatura degli indumenti dei nostri avi e a completamento una stanza da letto,
munita degli accessori di una volta.
Nella parte finale si possono visitare la stanza dedicata alle unità
di peso e misura e una stanza con alcuni oggetti usati per il tempo libero.
Accanto uno spazio che racconta il percorso del vino, con gli attrezzi e gli
oggetti usati dai nonni.
Nella parte del Museo che si affaccia al grande Chiostro del 1500, sono state
allestite alcune sale dedicate ai lavori di quel tempo :
La Sala della Scuola e dei Giochi, la Sala della lavorazione della lana e della canapa,
la Sala del Calzolaio, la Sala del Falegname, e infine quella del fabbro
“ favaro “ e dell’arrotino “ moleta “ .
All’interno del Museo è stata prevista una Sala per le attività didattiche che
possono essere svolte dai bambini della Scuola Primaria durante la visita al
complesso Abbaziale.
Il percorso proposto per la visita al Museo rappresenta una testimonianza del lavoro svolto
dalle comunità dei Monaci Agostiniani e Camaldolesi per rendere viva e
autosufficiente l’esistenza dei nostri avi.





 Appartiene all’inizio del monachesimo dell’Abbazia di Carceri e sorge come unica porta
di accesso al monastero: è separato dalle strutture dedicate alla vita dei
monaci, ma direttamente collegato alla Foresteria. Il portico, costruito dagli
Agostiniani, è un edificio a pianta rettangolare, sottoposto a continui
rimaneggiamenti. È costituito da un arco a fornice a sesto ribassato, che
durante la notte veniva sbarrato da un pesante portone. Sopra si apre una loggetta a
quattro archi e nella parte più alta fa bella vista una serie di merli a “coda di
rondine“ , costruiti dai Conti Carminati a scopo ornamentale. Di fianco all’ingresso,
si eleva alta e leggera la torre di guardia abbellita da un piccolo portico
ornamentale. Adiacente alla torre si trovava l’abitazione del Padre Foresterario
collegata, attraverso un porticato, alla Foresteria, struttura adibita all’accoglienza
e all’ospitalità di pellegrini di passaggio o di ospiti permanenti. Dal 14
giugno 2015 la casa del Padre Foresterario è stata completamente restaurata e
resa la sede del Centro di Spiritualità Scout, con lo scopo di formare ed
educare alla fede i gruppi Scout della Regione Veneto.
Appartiene all’inizio del monachesimo dell’Abbazia di Carceri e sorge come unica porta
di accesso al monastero: è separato dalle strutture dedicate alla vita dei
monaci, ma direttamente collegato alla Foresteria. Il portico, costruito dagli
Agostiniani, è un edificio a pianta rettangolare, sottoposto a continui
rimaneggiamenti. È costituito da un arco a fornice a sesto ribassato, che
durante la notte veniva sbarrato da un pesante portone. Sopra si apre una loggetta a
quattro archi e nella parte più alta fa bella vista una serie di merli a “coda di
rondine“ , costruiti dai Conti Carminati a scopo ornamentale. Di fianco all’ingresso,
si eleva alta e leggera la torre di guardia abbellita da un piccolo portico
ornamentale. Adiacente alla torre si trovava l’abitazione del Padre Foresterario
collegata, attraverso un porticato, alla Foresteria, struttura adibita all’accoglienza
e all’ospitalità di pellegrini di passaggio o di ospiti permanenti. Dal 14
giugno 2015 la casa del Padre Foresterario è stata completamente restaurata e
resa la sede del Centro di Spiritualità Scout, con lo scopo di formare ed
educare alla fede i gruppi Scout della Regione Veneto.
 La struttura sobria e armoniosa della costruzione appare adatta a documentare
l’esercizio dell’ospitalità curata dai Monaci come prescritto dal capitolo 53
della Regola di San Benedetto, nel quale egli delinea il rito dell’accoglienza e
raccomanda una cura particolare per gli ospiti poveri e per i pellegrini. È un
edificio imponente, architettonicamente parlando, il più bello e armonioso di tutta
la struttura Abbaziale. Il piano terra, costruito dai Monaci Agostiniani verso il
1200, con circa mille metri quadrati di superficie era lo spazio adibito ai servizi di
accoglienza e ospitalità. Con l’avvento dei Monaci Camaldolesi la Foresteria
fu elevata di un piano, poggiando, sui muri centrali del piano terra, possenti
colonne in muratura che sostengono la struttura del tetto, attualmente completamente
ristrutturato.
La struttura sobria e armoniosa della costruzione appare adatta a documentare
l’esercizio dell’ospitalità curata dai Monaci come prescritto dal capitolo 53
della Regola di San Benedetto, nel quale egli delinea il rito dell’accoglienza e
raccomanda una cura particolare per gli ospiti poveri e per i pellegrini. È un
edificio imponente, architettonicamente parlando, il più bello e armonioso di tutta
la struttura Abbaziale. Il piano terra, costruito dai Monaci Agostiniani verso il
1200, con circa mille metri quadrati di superficie era lo spazio adibito ai servizi di
accoglienza e ospitalità. Con l’avvento dei Monaci Camaldolesi la Foresteria
fu elevata di un piano, poggiando, sui muri centrali del piano terra, possenti
colonne in muratura che sostengono la struttura del tetto, attualmente completamente
ristrutturato.
 Procedendo verso la Chiesa, a destra della facciata, si trova il palazzo canonicale.
Riassume fra le sue mura le vicende dell’Abbazia, anche perché la sua struttura
risulta stravolta dagli eventi succedutesi nel tempo. Attualmente è sede della
canonica Parrocchiale. La villa, costruita dai Monaci Agostiniani come residenza del
Padre Superiore, poi, con i Camaldolesi diventa sede dell’Abbazia Camaldolese. Nel
1690 l’Abbazia viene trasformata in una imponente azienda agricola e la villa assume
il ruolo di residenza della nobile famiglia dei Conti Carminati. Oggi, dopo gli
interventi per il restauro del tetto e del piano terra, è diventata canonica
Parrocchiale. All’esterno, sulla facciata, oltre allo stemma dei Camaldolesi, appare
anche quello dei Conti Carminati, un’aquila a due teste sopra un carro agricolo colmo
di spighe, indice della trasformazione del monastero in azienda agricola.
Procedendo verso la Chiesa, a destra della facciata, si trova il palazzo canonicale.
Riassume fra le sue mura le vicende dell’Abbazia, anche perché la sua struttura
risulta stravolta dagli eventi succedutesi nel tempo. Attualmente è sede della
canonica Parrocchiale. La villa, costruita dai Monaci Agostiniani come residenza del
Padre Superiore, poi, con i Camaldolesi diventa sede dell’Abbazia Camaldolese. Nel
1690 l’Abbazia viene trasformata in una imponente azienda agricola e la villa assume
il ruolo di residenza della nobile famiglia dei Conti Carminati. Oggi, dopo gli
interventi per il restauro del tetto e del piano terra, è diventata canonica
Parrocchiale. All’esterno, sulla facciata, oltre allo stemma dei Camaldolesi, appare
anche quello dei Conti Carminati, un’aquila a due teste sopra un carro agricolo colmo
di spighe, indice della trasformazione del monastero in azienda agricola.
 Uscendo dal palazzo canonicale si impone allo sguardo la facciata della Chiesa nella
sua maestosa armonia. Le statue, situate in alto sopra il timpano, raffigurano Dio
Padre, Maria e l’arcangelo Gabriele nel momento dell’Annunciazione. Chiunque,
varcato il portico d’entrata, può intuire a chi era dedicato il sito
religioso. La facciata attuale è la terza, risulta da un restauro ad opera
dei Monaci Camaldolesi dell’anno 1686 “meliori culto exornata”, come si vede dalla
lapide sopra l’ingresso.
Presenta una ricca trabeazione che si articola in due
ordini. In quello superiore si possono ammirare rigonfiamenti e scanalature
intercalate da nicchie, che ospitano le statue di San Pietro e San Paolo. Sui lati
esterni le statue di San Benedetto, fondatore dell’Ordine dei Benedettini, e San
Romualdo fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.
Uscendo dal palazzo canonicale si impone allo sguardo la facciata della Chiesa nella
sua maestosa armonia. Le statue, situate in alto sopra il timpano, raffigurano Dio
Padre, Maria e l’arcangelo Gabriele nel momento dell’Annunciazione. Chiunque,
varcato il portico d’entrata, può intuire a chi era dedicato il sito
religioso. La facciata attuale è la terza, risulta da un restauro ad opera
dei Monaci Camaldolesi dell’anno 1686 “meliori culto exornata”, come si vede dalla
lapide sopra l’ingresso.
Presenta una ricca trabeazione che si articola in due
ordini. In quello superiore si possono ammirare rigonfiamenti e scanalature
intercalate da nicchie, che ospitano le statue di San Pietro e San Paolo. Sui lati
esterni le statue di San Benedetto, fondatore dell’Ordine dei Benedettini, e San
Romualdo fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.
 L’attuale Chiesa è opera dei Camaldolesi, sui resti della chiesa
Portuense e di quella a tre navate, tutte e due incendiate. Nel 1686 viene consacrata
dal Vescovo di Padova San Gregorio Barbarigo, è costruita su pianta
rettangolare con angoli smussati che rendono l’unica navata di forma ellissoidale. Il
soffitto si alza a vela e tre ordini di finestre consentono una gradevole luminosit
à. Entrando, le tre cappelle di destra raffigurano l’altare
L’attuale Chiesa è opera dei Camaldolesi, sui resti della chiesa
Portuense e di quella a tre navate, tutte e due incendiate. Nel 1686 viene consacrata
dal Vescovo di Padova San Gregorio Barbarigo, è costruita su pianta
rettangolare con angoli smussati che rendono l’unica navata di forma ellissoidale. Il
soffitto si alza a vela e tre ordini di finestre consentono una gradevole luminosit
à. Entrando, le tre cappelle di destra raffigurano l’altare
 di Sant’Isidoro, l’altare con la recente immagine della Madonna e l’altare con la
pala della Crocifissione, attribuita alla scuola di Guido Reni. Sul lato sinistro, si
trovano gli altari di Santa Lucia con Sant’Antonio da Padova, l’altare di San Bellino
Vescovo di Padova e l’altare di San Romualdo, fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.
Percorsa la navata si accede ad una delle parti rimaste dopo gli incendi delle chiese
precedenti, Portuense e Camaldolese, ora adibita a Presbiterio. Nelle pareti laterali
appaiono due lunette dipinte, sulla destra il trasporto della salma di San Teobaldo
all’Abbazia della Vangadizza, sulla sinistra la rappresentazione di un ferito soccorso
dal buon Samaritano che potrebbe essere San Romualdo. Al di là del
Presbiterio rimane il Coro della seconda chiesa. È privo dei pregevoli stalli
che, venduti nel periodo dei Conti Carminati, si trovano, ora, nel Duomo di Chioggia e
nel Palazzo Ducale di Venezia. Sopra la trabeazione
del Coro è posto un quadro raffigurante l’Annunciazione, opera di notevole
valore di Luca da Reggio della scuola di Guido Reni.
di Sant’Isidoro, l’altare con la recente immagine della Madonna e l’altare con la
pala della Crocifissione, attribuita alla scuola di Guido Reni. Sul lato sinistro, si
trovano gli altari di Santa Lucia con Sant’Antonio da Padova, l’altare di San Bellino
Vescovo di Padova e l’altare di San Romualdo, fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi.
Percorsa la navata si accede ad una delle parti rimaste dopo gli incendi delle chiese
precedenti, Portuense e Camaldolese, ora adibita a Presbiterio. Nelle pareti laterali
appaiono due lunette dipinte, sulla destra il trasporto della salma di San Teobaldo
all’Abbazia della Vangadizza, sulla sinistra la rappresentazione di un ferito soccorso
dal buon Samaritano che potrebbe essere San Romualdo. Al di là del
Presbiterio rimane il Coro della seconda chiesa. È privo dei pregevoli stalli
che, venduti nel periodo dei Conti Carminati, si trovano, ora, nel Duomo di Chioggia e
nel Palazzo Ducale di Venezia. Sopra la trabeazione
del Coro è posto un quadro raffigurante l’Annunciazione, opera di notevole
valore di Luca da Reggio della scuola di Guido Reni.
 È l’unica torre d’angolo rimasta del Chiostro Romanico, tutte le immagini
rappresentate sulle pareti sono pagine della Bibbia. Ora il locale è adibito
a fonte battesimale con una bella vasca ottagonale al centro. Il Battistero, con il
Presbiterio, il Coro e una parte del campanile, appartiene ai resti salvati
dall’incendio del 1242, al tempo degli Agostiniani e restaurati con la chiesa a tre
navate. L’interno, con volta a crociera, conserva nelle quattro pareti degli affreschi
che possono sembrare stilisticamente differenti ma in realtà fanno tutti parte
del periodo Camaldolese. Di fronte all’entrata l’Annunciazione, sulla destra la
Crocifissione, sulla sinistra lo splendore della Pentecoste, e sopra la porta
d’ingresso si può ammirare la Resurrezione. Tutti gli affreschi sono collegati
al centro della volta dove è rappresentato Dio Padre.
È l’unica torre d’angolo rimasta del Chiostro Romanico, tutte le immagini
rappresentate sulle pareti sono pagine della Bibbia. Ora il locale è adibito
a fonte battesimale con una bella vasca ottagonale al centro. Il Battistero, con il
Presbiterio, il Coro e una parte del campanile, appartiene ai resti salvati
dall’incendio del 1242, al tempo degli Agostiniani e restaurati con la chiesa a tre
navate. L’interno, con volta a crociera, conserva nelle quattro pareti degli affreschi
che possono sembrare stilisticamente differenti ma in realtà fanno tutti parte
del periodo Camaldolese. Di fronte all’entrata l’Annunciazione, sulla destra la
Crocifissione, sulla sinistra lo splendore della Pentecoste, e sopra la porta
d’ingresso si può ammirare la Resurrezione. Tutti gli affreschi sono collegati
al centro della volta dove è rappresentato Dio Padre.
 Il Chiostrino Romanico appartiene alla fase
costruttiva dei primi Padri Agostiniani.
Rimane solamente un lato, ma sufficiente per
farci capire come doveva essere
l’insieme: uno dei più belli del Veneto e
probabilmente anche unico nel suo genere per
l’epoca e per lo stile. Il chiostrino è costituito da 24 colonnine
monolitiche
l'epoca e per lo stile. Il chiostrino è
costituito da 24 colonnine monolitiche
in marmo rosso di Verona, variamente
abbinate e composite, che sostengono altrettanti
capitelli e archetti, tanto da formare una
struttura graziosa e leggera alla vista,
ma solida tanto da sostenere una parete in
muratura massiccia e pesante. Il posto,
almeno per i Monaci Agostiniani,
rappresentava il Chiostro Silente, con al centro del
rombo il lavabo, che univa il Refettorio
alla Chiesa. Oggi, al posto del lavabo, una
fontana in marmo rosso di Verona.
Il Chiostrino Romanico appartiene alla fase
costruttiva dei primi Padri Agostiniani.
Rimane solamente un lato, ma sufficiente per
farci capire come doveva essere
l’insieme: uno dei più belli del Veneto e
probabilmente anche unico nel suo genere per
l’epoca e per lo stile. Il chiostrino è costituito da 24 colonnine
monolitiche
l'epoca e per lo stile. Il chiostrino è
costituito da 24 colonnine monolitiche
in marmo rosso di Verona, variamente
abbinate e composite, che sostengono altrettanti
capitelli e archetti, tanto da formare una
struttura graziosa e leggera alla vista,
ma solida tanto da sostenere una parete in
muratura massiccia e pesante. Il posto,
almeno per i Monaci Agostiniani,
rappresentava il Chiostro Silente, con al centro del
rombo il lavabo, che univa il Refettorio
alla Chiesa. Oggi, al posto del lavabo, una
fontana in marmo rosso di Verona.
 È adiacente a quel che resta del Chiostro Romanico e viene costruito verso la
metà del 1500 dai Camaldolesi, entrati nel Monastero per decisione del Papa
Gregorio XII, con lo scopo di favorire il riordino morale e materiale del luogo. Il
chiostro è modellato nello stile del Rinascimento: presenta ampi archi,
sostenuti da colonne toscane, sovrastate da una bella trabeazione che divide il
porticato dal piano superiore con le finestre delle celle dei Monaci. L’elegante
loggia sopraelevata presenta svelte colonne con volute coniche, dalla quale è
possibile ammirare l’armonia dell’intero chiostro. Il chiostro, originariamente,
ospitava le aule di lezione, di studio, di riposo e di sorveglianza. Nel mezzo del
chiostro un pozzo monumentale di marmo rosso conferisce signorilità ed esalta
lo stemma dei Camaldolesi: due colombe che si abbeverano allo stesso calice, simbolo
di Eremiti e Cenobiti che attingono forza da Cristo.
È adiacente a quel che resta del Chiostro Romanico e viene costruito verso la
metà del 1500 dai Camaldolesi, entrati nel Monastero per decisione del Papa
Gregorio XII, con lo scopo di favorire il riordino morale e materiale del luogo. Il
chiostro è modellato nello stile del Rinascimento: presenta ampi archi,
sostenuti da colonne toscane, sovrastate da una bella trabeazione che divide il
porticato dal piano superiore con le finestre delle celle dei Monaci. L’elegante
loggia sopraelevata presenta svelte colonne con volute coniche, dalla quale è
possibile ammirare l’armonia dell’intero chiostro. Il chiostro, originariamente,
ospitava le aule di lezione, di studio, di riposo e di sorveglianza. Nel mezzo del
chiostro un pozzo monumentale di marmo rosso conferisce signorilità ed esalta
lo stemma dei Camaldolesi: due colombe che si abbeverano allo stesso calice, simbolo
di Eremiti e Cenobiti che attingono forza da Cristo.
 tutte le pareti e attribuiti alla scuola del Salviati. Ogni figura è collocata
a fianco di colonne scanalate e rettangolari, con i piedi che poggiano su una piccola
base a sua volta collocata sopra un capitello. Pare proprio che le figure abbiano una
propria volumetria, non solo grazie a questa finta architettura, ma anche grazie
all’ariosità dei panneggi. Di particolare efficacia è la
rappresentazione della Madonna Annunciata e dell’Angelo Nunziante, che sembra
rassicurarla dopo averle comunicato il lieto evento. Fra le due figure l’immagine di
Isaia con il rotolo della sua profezia. Altre figure dell’Antico e del Nuovo
Testamento, in parte legate alla vita dell’Abbazia, arricchiscono la Sala degli
Affreschi. Attualmente la Sala, molto apprezzata dai visitatori, è anche
riservata ad eventi letterari, riunioni, mostre pittoriche e fotografiche.
tutte le pareti e attribuiti alla scuola del Salviati. Ogni figura è collocata
a fianco di colonne scanalate e rettangolari, con i piedi che poggiano su una piccola
base a sua volta collocata sopra un capitello. Pare proprio che le figure abbiano una
propria volumetria, non solo grazie a questa finta architettura, ma anche grazie
all’ariosità dei panneggi. Di particolare efficacia è la
rappresentazione della Madonna Annunciata e dell’Angelo Nunziante, che sembra
rassicurarla dopo averle comunicato il lieto evento. Fra le due figure l’immagine di
Isaia con il rotolo della sua profezia. Altre figure dell’Antico e del Nuovo
Testamento, in parte legate alla vita dell’Abbazia, arricchiscono la Sala degli
Affreschi. Attualmente la Sala, molto apprezzata dai visitatori, è anche
riservata ad eventi letterari, riunioni, mostre pittoriche e fotografiche.
